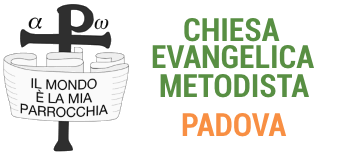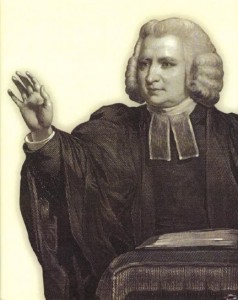Il Metodismo
Il Metodismo è sorto meno di tre secoli fa ma si è sviluppato con un ritmo tale da presentarsi oggi come una delle più importanti realtà evangeliche.
Le origini del movimento metodista risalgono ad un gruppo di studenti dell’Università di Oxford che decise di riunirsi per studiare la Scrittura, pregare, assistere i poveri, gli infermi e i carcerati. Il cenacolo religioso, guidato dai fratelli John (1703- 91) e Charles Wesley (1708-88), divenne noto come Holy Club e i suoi aderenti furono soprannominati «metodisti» a motivo dell’organizzazione metodica della loro giornata.
I fratelli Wesley dedicarono tutte le loro energie ad un’instancabile attività di evangelizzazione della popolazione che non frequentava alcuna chiesa. John Wesley, che era un ministro di culto della Chiesa d’Inghilterra, non aveva la minima intenzione di creare una nuova chiesa. Quando però l’opposizione ai suoi metodi non tradizionali gli rese sempre più difficile predicare dai pulpiti delle chiese, iniziò a predicare all’aperto, sulle piazze e per le strade e la sua predicazione, unitamente a quella di altri ministri che seguirono il suo esempio, portò alla conversione di un numero sempre maggiore di persone. Wesley si preoccupò fin dall’inizio di organizzare i nuovi convertiti in una rete di «società» e «classi» (ecclesiolae in ecclesia), che costituirono il nucleo iniziale del movimento metodista, che si stava strutturando in una nuova denominazione già alla morte del suo fondatore.
Ben presto alle «classi» si affiancarono scuole per adulti e ragazzi, consultori medici gratuiti per i poveri, inaugurando quell’unione tra predicazione e azione sociale che diventerà una delle caratteristiche del metodismo.
La stessa predicazione, inizialmente affidata solo a ministri ordinati della Chiesa anglicana, fu affidata anche a «predicatori locali», persone devote e preparate che durante la settimana svolgevano una normale attività lavorativa e alla domenica avevano la responsabilità del culto per le classi di una stessa località. Inoltre, cosa ancora più scandalosa per le autorità ecclesiastiche anglicane, questo incarico venne esteso anche alle donne.
Il movimento metodista, anche grazie alle capacità organizzative di Wesley, si diffuse nelle isole britanniche e nelle colonie americane, dove nel 1784 si costituì la Chiesa metodista episcopale. Anche in Inghilterra, nello stesso anno, le crescenti difficoltà nei rapporti con i vescovi e il clero anglicano indussero Wesley a dare una forma istituzionale al movimento che, riconosciuto come «non-conformista» (cioè indipendente dalla chiesa di stato), poté godere del diritto alla libertà di culto sancita dall’Editto di tolleranza del 1689. Dopo la morte di Wesley, il movimento metodista accentuò il processo di autonomia e nel 1795 finì per dare origine ad una nuova chiesa protestante.
Il metodismo non ha posto l’accento né sulle dottrine né sul culto, ma sulla vita pratica e sulle esperienze religiose: la prima, essenziale, è la conversione («nuova nascita»). Come Wesley la sera del 24 maggio 1738, ogni credente deve conoscere una profonda crisi, nella quale si rende conto della gravità dei suoi peccati, e nello stesso tempo sente con assoluta certezza che Dio lo perdona e lo salva. Con la conversione inizia un lungo processo di trasformazione spirituale: lasantificazione. Il convertito cresce in amore e pietà fino a giungere al vero amore di Dio e del prossimo. Wesley aveva fiducia nella possibilità di realizzare in questo mondo la perfezione cristiana, e così faceva rivivere l’aspirazione puritana in un’ atmosfera di fervida pietà.
Il metodismo si è diffuso in tutto il mondo. I membri comunicanti sono oltre 25 milioni e la popolazione complessiva supera i 50, di cui circa la metà negli Stati Uniti. A questa cifra vanno aggiunti alcuni milioni di metodisti che in varie parti del mondo sono entrati a far parte di “chiese unite”. In Italia i metodisti, benché numericamente esigui (oggi 39 comunità con una popolazione di 6.000 persone), hanno dato al protestantesimo italiano tutta una serie di personalità creative, pionieri d’azione sociale. I metodisti hanno poi dato un impulso decisivo alla nascita e allo sviluppo della Federazione delle Chiese Evangeliche.
Liberamente tratto ed adattato da
G. Bouchard, Chiese e movimenti evangelici del nostro tempo. Torino, Claudiana, 2006, pp. 77-78
M. Rubboli, I protestanti. Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 73-74
La Chiesa Evangelica Valdese
Da più di 830 anni il nome «valdese» designa un movimento evangelico minoritario, ma aperto e ben radicato nella realtà sociale del nostro paese e di alcune altre nazioni.
All’origine c’è la vocazione di un uomo: Valdo (Valdès, in latino Valdesius) era un ricco mercante di Lione, che a metà della sua vita (nel 1174 circa) attraversò una folgorante crisi spirituale. Posto dinanzi al ben noto episodio evangelico del «giovane ricco» (Mc 10,17 – 31) decise di applicarlo alla lettera: donò ai bisognosi larga parte dei suoi beni, e poi decise di vivere con loro, povero tra i poveri: i suoi seguaci furono perciò chiamati Poveri di Lione. L’analogia con quanto sarebbe accaduto trent’anni dopo a Francesco d’Assisi è evidente. Ma Valdo è in un certo senso più radicale: fa tradurre la Bibbia e si mette, lui semplice laico, a predicare in mezzo al popolo. Lo scontro con la gerarchia cattolica era perciò inevitabile, e fu particolarmente duro: ma la repressione non impedì al movimento di espandersi in tutta Europa: dopo pochi anni i valdesi erano fortemente presenti a Milano e in tutta l’Italia settentrionale, dove presero il nome di «Poveri lombardi» e raccolsero l’eredità di vari altri movimenti ereticali. Da Milano, i valdesi si diffusero in Austria, Germania, Boemia, Ungheria, Polonia e Italia centro-meridionale.
Struttura portante del movimento erano i predicatori itineranti (i «barba») e numerosi nuclei clandestini (gli «ospizi»). La loro base teologica riposava su di una fedele applicazione del Sermone sul monte (Matteo 5 – 7): povertà, rifiuto della menzogna, della guerra, del giuramento, critica di una chiesa ricca e potente. La chiesa e gli stati furono concordi nel considerare questa teologia come pericolosamente sovversiva e, dopo tre secoli di implacabile persecuzione, riuscirono a emarginare il movimento valdese: tuttavia alcuni nuclei consistenti si mantennero in Calabria, Puglia e sui due versanti delle Alpi Occidentali (Piemonte, Delfinato, Provenza).
Con l’affermarsi della Riforma in Europa i valdesi decisero di aderire alla Riforma. Da una parte, questa decisione costò loro molto cara: i valdesi di Provenza (1545) e Calabria (1561) furono sterminati, e solo una fortunata guerriglia impedì ai valdesi del Piemonte di subire la stessa sorte (1560-61).
D’altra parte, il gruppo sopravvissuto nelle Valli valdesi del Piemonte, ormai garantito dall’Accordo di Cavour (5 giugno 1561), sviluppò un notevole senso di identità non privo d’un respiro universale: nasceva il «popolo valdese»:
Nel 1686 il popolo valdese fu a un passo dall’estinzione: gli eserciti del re di Francia Luigi XIV e del duca di Savoia Vittorio Amedeo II schiacciarono la resistenza valdese con uno spietato massacro, e nell’inverno 1687 i valdesi sopravvissuti alle carceri piemontesi (3.000) furono espulsi verso la Svizzera e la Germania.
Nel 1689, con una marcia fortunosa (il «Glorioso Rimpatrio»), poterono rientrare in Piemonte. Dopo un anno di guerriglia il duca li reintegrò nei loro diritti (1690); in realtà, era lo spirito del nascente mondo liberai-democratico (Guglielmo III d’Orange, governatore dei Paesi Bassi e dal 1688 re d’Inghilterra) che aveva salvato i valdesi.
I valdesi impiegarono tutto il XVIII secolo a ricostruire il loro piccolo mondo, e lo fecero intorno a due punti cardinali: un’organizzazione di tipo democratico (l’autonomia della comunità locale, il Sinodo formato da laici e pastori, la Tavola valdese come ente rappresentativo e organo di coordinamento), e una viva attenzione ai problemi della cultura che si manifestò con il Risveglio (1825) che mise la Chiesa valdese in condizione di affrontare creativamente la svolta del Risorgimento: civilmente parificati agli altri cittadini con le «Patenti» del 17 febbraio 1848, i valdesi crearono nuove comunità in tutta Italia e, grazie all’ emigrazione, anche in Uruguay e Argentina (1857): oggi circa un terzo dei valdesi parla spagnolo e costituisce la Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata. I valdesi emigrati negli Stati Uniti aderirono invece alle chiese protestanti del luogo (soprattutto ai presbiteriani). Questa emigrazione è stata in parte compensata dall’adesione di alcune comunità di origine svizzera o mitteleuropea (Torino, Bergamo, Trieste etc.).
Il XX secolo ha visto un accentuarsi della responsabilità sociale e culturale. Fondamentali per la vita della chiesa sono la Facoltà valdese di Teologia (Roma), oggi al centro di una vasta rete di rapporti ecumenici, la casa editrice Claudiana (Torino), il settimanale Riforma, dal 1993 organo comune delle chiese battiste, metodiste e valdesi, il Centro culturale valdese di Torre Pellice, la Società di studi valdesi, il Centro ecumenico di Agape (Prali, nelle Valli valdesi); ma esistono numerose altre iniziative, tra cui segnaliamo il Collegio Valdese (liceo) di Torre Pellice oltre a case di riposo, centri di accoglienza etc.
Nel 1979 è venuto a compimento un lungo processo di integrazione con le chiese metodiste che sono in Italia.
Liberamente tratto ed adattato da
G. Bouchard, Chiese e movimenti evangelici del nostro tempo. Torino, Claudiana, 2006, pp. 117-120
Unione delle Chiede Metodiste e Valdesi
Le tradizioni delle due chiese sono state combinate in modo da salvaguardare le rispettive identità, ma la vita ecclesiastica è integrata a tutti i livelli: esiste un unico corpo pastorale, un unico Sinodo e la Tavola Valdese è composta da cinque valdesi e due metodisti e la base teologica del Patto d’integrazione (1975) è la cosiddetta Confessione di fede valdese del 1655.
Il primo «atto pubblico» di una certa risonanza compiuto dalla Chiesa unita è stata la firma dell’Intesa con la Repubblica italiana (Roma, 21 febbraio 1984). Il secondo è stata la comune commemorazione del Glorioso Rimpatrio (1989). Il terzo, la solenne celebrazione (anche in Parlamento) dei 150 anni dell’emancipazione valdese, unitamente alla comunità ebraica (1998).
Dopo il 1979 il nome ufficiale della Chiesa integrata è Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi). Essa raggiunge un’area complessiva (tra credenti, simpatizzanti e persone di tradizione protestante) di circa 50.000 persone, di cui 6.000 metodisti, 15.000 valdesi sudamericani e 30.000 valdesi in Italia (con quattro gruppi in Svizzera).
La Chiesa Evangelica Valdese raccoglie il 10% del protestantesimo italiano, ma ne costituisce la parte più «visibile» e mantiene una certa egemonia sul piano teologico e culturale. Numerosi docenti universitari e alcuni membri del Parlamento appartengono all’area valdese.
La Chiesa valdese è sempre attenta ai temi della laicità, come dimostra il lavoro della commissione di bioetica nominata dalla Tavola valdese fin dal 1992. Problemi delicatissimi quali la bioetica, la fecondazione assistita e l’eutanasia sono stati portati all’attenzione delle chiese, riscuotendo significativi consensi.
Membro fondatore del Consiglio Ecumenico delle Chiese, la chiesa dei valdesi e metodisti è molto impegnata sul fronte ecumenico internazionale e, a livello italiano, nel dialogo interconfessionale sia sul versante cattolico sia su quello evangelico.
Liberamente tratto ed adattato da
G. Bouchard, Chiese e movimenti evangelici del nostro tempo. Torino, Claudiana, 2006, pp. 120-123