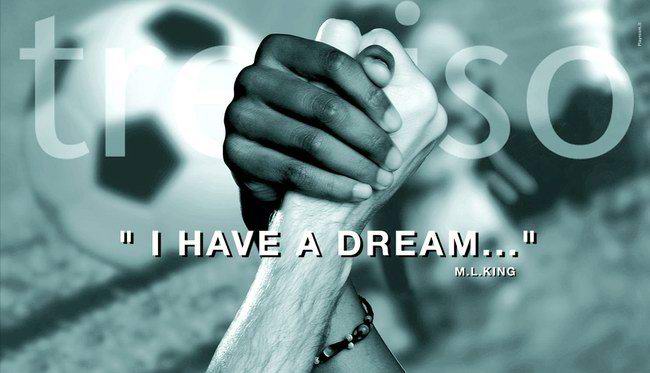Sermone: PREDICAZIONE DI DOMENICA 20 GENNAIO 2013 (Mt 17: 1-9, Sal 36: 5-9, 2 Cor 4: 5-6)
TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNORE
Il passo di Matteo riferisce meglio che può, perché qui Matteo, e con lui Marco e Luca, si trovano alle prese con l’esigenza di esprimere l’indicibile, quell’evento singolare e misterioso che è la trasfigurazione di Gesù. Di questo episodio evangelico, la Chiesa cattolica romana e le Chiese orientali fanno memoria il 6 agosto; il mondo protestante, invece, non gli dedica espressamente una commemorazione liturgica in una particolare domenica. È per questa domenica di gennaio, tuttavia, che il nostro lezionario ci propone la narrazione della Trasfigurazione tramandataci da Matteo. Mi sembra una collocazione tutt’altro che inopportuna, rispondente, anzi, a una logica interna del calendario liturgico che, da Natale all’Epifania, ci ha invitati a concentrare la nostra attenzione sul tema della manifestazione del Signore, della manifestazione della gloria divina tra gli esseri umani, in una serie di momenti, di tappe: la manifestazione ai pastori, la manifestazione ai magi, la manifestazione avvenuta sul fiume Giordano. Anche l’episodio della Trasfigurazione è una manifestazione, ma di carattere diverso dalle precedenti. Prima, l’Onnipotente si nascondeva sotto le spoglie di un neonato indifeso o di un uomo non diverso dai tanti altri che accorrevano al fiume per ricevere il battesimo di Giovanni, e per decifrarne la vera natura era necessario un messaggio angelico, o l’intervento dello Spirito Santo; mentre qui i tre discepoli sul monte ricevono una rivelazione diretta della natura divina di Gesù, una sorta di flash abbagliante che preannuncia lo splendore del Risorto. È per questo che alla fine della visione Gesù rivolge ai discepoli confusi e turbati l’esortazione “Non temete”, cioè l’invito che sempre nella Scrittura si accompagna a una manifestazione del divino. Matteo e gli altri sinottici, dicevo, nel narrare questo episodio cercano parole per comunicare un’esperienza che non può essere comunicata con parole umane. È un’impresa ardua ma affascinante, nella quale si sono cimentati anche tanti pittori: grandi maestri della pittura occidentale e innumerevoli autori di icone orientali, perché il tema della Trasfigurazione è particolarmente sentito nella spiritualità e, di conseguenza, nell’arte del mondo ortodosso. Ma torniamo al nostro testo. L’episodio della Trasfigurazione è immediatamente preceduto da un versetto misterioso: “alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il Figlio dell’uomo venire nel suo regno” (Mt 16: 28). E poco prima c’era stata la confessione di Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16: 16). È dopo la confessione di Pietro e dopo l’annuncio della venuta del Figlio dell’uomo che Gesù prende con sé tre discepoli e si trasfigura davanti a loro. Matteo vuol farci capire che la parola di Gesù si è realizzata nella trasfigurazione. Dopo che Pietro lo ha riconosciuto come messia, Gesù offre una primizia del regno a tre discepoli, portandoli soli su un’alta montagna – e sappiamo bene che nella Bibbia l’“alta montagna” ha sempre un significato particolare. Che cosa è avvenuto, dunque, su quel monte? Per noi è impossibile descriverlo, così come è impossibile agli evangelisti. Si può dire soltanto che si è trattato di un’esperienza abbagliante: il volto di Gesù “risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce”. Marco, nel passo corrispondente a questo di Matteo (Mc 9: 2-7), diventa addirittura un po’ comico quando dice che le vesti di Gesù erano “di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare”. L’imbarazzo, la goffaggine perfino, degli evangelisti rivelano l’incapacità di dire ciò che gli occhi trasformati dei discepoli hanno visto in quella circostanza, hanno visto di Gesù e intorno a Gesù. Ho parlato di “occhi trasformati”, e non a caso: la lettura che di questo episodio fanno i Padri della chiesa d’Oriente dice infatti che in realtà non Gesù si trasfigurò, ma si trasfigurarono gli occhi dei discepoli, che riuscirono così a vedere il loro Maestro per quello che veramente era. Le icone orientali fanno partire dalla figura di Cristo dei raggi che vanno a colpire gli occhi dei discepoli. Certamente, i discepoli videro che Gesù aveva un’altra forma: “fu trasfigurato davanti a loro” equivale a “cambiò aspetto, subì una metamorfosi”. Videro, i discepoli, qualcosa di “totalmente altro” rispetto alla loro quotidiana esperienza di Gesù: videro un volto pieno di luce, videro vesti gloriose come quelle dei giusti secondo la Bibbia ebraica. Capirono in profondità, con una profondità che andava ben oltre la confessione che Gesù era il messia: come era avvenuto in occasione del battesimo. Ritorno a quanto dicevo prima: questa scena è uno sviluppo della scena del battesimo, è un momento eccezionale in cui Pietro, Giacomo e Giovanni riescono a sentire quello che Gesù ha sentito lui solo al battesimo. Ma lo sentono mentre accanto a Gesù vedono la Legge (Mosè) e i profeti (Elia), vedono cioè il Primo Testamento che testimonia di lui. Elia, il profeta atteso per la fine dei tempi, indica Gesù come il compimento delle Scritture, indica Gesù come Colui nel quale la Legge e i profeti si adempiono. E poi ecco la “voce dalla nuvola” (e sappiamo come nella Bibbia ebraica la nuvola racchiuda spesso una presenza divina). La voce non solo ripete le parole del battesimo, ma aggiunge qualcosa di molto importante: shemà, ascolta. È Gesù che ora bisogna ascoltare. In questa teofania noi abbiamo il cuore del vangelo: dalla confessione di Pietro si arriva alla confessione del Padre su Gesù a Pietro, Giacomo e Giovanni. D’ora in poi i discepoli dovranno vedere in Gesù colui che realizza la Legge e i profeti. Luca (cfr. Lc 9: 28-35) aggiungerà che Mosè ed Elia “parlavano” con Gesù “della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme”, gli stavano dicendo, cioè, quello che lo attendeva, la passione, la morte e la resurrezione. Il significato è sempre quello: la predicazione di Gesù, l’evangelo da lui annunciato, e la sua stessa vicenda terrena, ricevono ora l’avallo della Legge e dei profeti, di tutte le Scritture. Dunque la trasfigurazione radiosa, Mosè ed Elia, la voce dalle nuvole … e poi? Poi interviene Pietro. Il solito Pietro, verrebbe da dire: sempre pieno di amore per il suo Maestro ma anche sempre impulsivo, a volte inopportuno. Adesso parla di costruire tre tende. Parla a vanvera, parla tanto per dire qualcosa, sopraffatto da una situazione troppo nuova e troppo grande per lui: “non sapeva che cosa dire”, “non sapeva quello che diceva”, commentano infatti Marco (9: 6) e Luca (9: 33). Potremmo dire che qui, di nuovo, Pietro rappresenta una tentazione per Gesù: resta qui, nella gloria, non esporti a pericoli, non scendere a Gerusalemme. Ma, prima di tutto, Pietro vuol dire a Gesù: resta qui, certo nella tua gloria, certo con Mosè e con Elia, ma anche con noi, con noi discepoli, che abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di averti sempre vicino. Da un lato, è vero, questo è ancora una volta un “tentare” Gesù; ma in questo “tentare” il suo amato Maestro Pietro esprime una necessità umanissima, una necessità che, credo, tutti noi condividiamo. A ben pensarci, non parla poi tanto a vanvera. Nel Gesù trasfigurato Pietro ha riconosciuto, forse senza rendersene pienamente conto, la realizzazione del regno, la presenza del divino. Questo, logicamente, ha riempito lui e gli altri due discepoli di “gran timore”; ma si tratta di quello che potremmo chiamare un timore reverenziale, non dello spavento provocato da un Dio minaccioso. Non c’è nessuna minaccia in questa luce. Si tratta (Pietro e gli altri due lo percepiscono) di una luce buona, proprio perché viene da Dio; una luce che è quella stessa luce di cui parla spesso la Scrittura, per esempio nel salmo del quale abbiamo ascoltato alcuni versetti: la luce di Dio, la luce del regno – e “regno” significa pieno benessere materiale e spirituale, armonia di tutte le creature tra loro e di tutto il creato con Dio.C’è tanta nostalgia nascosta in queste parole di Pietro: nostalgia per un Dio “terrestre”, che stia con noi, che metta le sue tende in mezzo a noi, come dice Giovanni nel prologo del suo vangelo (1: 14), ma le metta per sempre, queste tende, non se ne vada, non ci abbandoni. E invece, talvolta, anzi troppo spesso, quegli uomini e quelle donne che si dicono credenti e che davvero vogliono esserlo, che con tanta fatica cercano di credere, si trovano di fronte a teologi, a ministri del culto, a coloro che potremmo definire i gestori dell’Evangelo, i quali talvolta, troppo spesso, cacciano Dio dalla terra per relegarlo nell’alto dei cieli, in modo tale che non si riesce più a vedere il suo volto splendente. Credo di non sbagliarmi affermando che questa è una difficoltà comune a tutte le chiese cristiane. Questa domenica cade nella settimana dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani: una ricerca di unità che, lo sappiamo, soprattutto nei tempi più recenti procede con grande fatica. Ma sappiamo, d’altra parte, che i cristiani sono già uniti sotto molti aspetti; ebbene, un ulteriore elemento di unità io lo riconosco proprio in questa nostalgia, che ci accomuna tutti, per un Dio che sia veramente l’Emmanuel, il Dio con noi, che ci illumini con la sua luce che altro non è che il suo amore, che ci sappia accarezzare, che asciughi le lacrime dai nostri occhi. Vorrei concludere con un’ultima considerazione. Il 6 agosto, per molte chiese giorno in cui si fa memoria di un Gesù che si trasforma in essere di luce, in sole radioso, è anche la ricorrenza di un sole di morte esploso il 6 agosto 1945 in Giappone. Nel 2006 il segretario generale della Conferenza delle chiese europee ha chiesto alle chiese membro di dedicare il 6 agosto alla preghiera per la pace. Mi sembra, questo, un forte richiamo a una presa di coscienza: il sole fabbricato dagli esseri umani è troppo spesso un sole creatore di morte. Solo se nei nostri cuori brillerà quella che Paolo chiama “la luce della conoscenza della gloria di Dio” potremo divenire veri testimoni della Trasfigurazione, e del regno che essa preannuncia. Solo nella via del servizio agli altri potremo “trasfigurare” la quotidianità che ci è stata affidata e farci, in ogni circostanza, portatori di pace.
(Sermone a cura della nostra Pastora, Caterina Griffante)