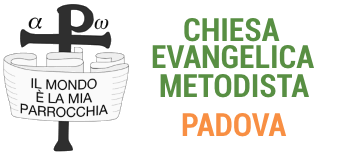Lamentazioni 3,1-40
Io sono l’uomo che ha visto l’afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca; mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l’accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino, e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce. Mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d’amarezza, mi ha abbeverato d’assenzio. Mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Io ho detto: «È sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore!»
Ricòrdati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell’assenzio e del veleno! Io me ne ricordo sempre, e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti; le sue compassioni infatti non sono esaurite; si rinnovano ogni mattina.
Grande è la tua fedeltà! «Il Signore è la mia parte», io dico, «perciò spererò in lui». Il Signore è buono con quelli che sperano in lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l’uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone! Metta la sua bocca nella polvere! Forse c’è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese! Il Signore infatti non respinge per sempre; ma, se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà; poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell’uomo.
Quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno vìola i diritti di un uomo in presenza dell’Altissimo, quando si fa torto a qualcuno nella sua causa, il Signore non lo vede forse? Chi mai dice una cosa che si avveri, se il Signore non l’ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell’Altissimo? Perché si rammarica la creatura vivente? L’uomo vive malgrado i suoi peccati!
Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola, e torniamo al Signore!
Strano il libro delle Lamentazioni e forse poco frequentato. Eppure, se lo leggiamo, troviamo in esso molto di noi stessi, molte nostre emozioni, molti nostri pensieri. In questo passo mi sono sentita coinvolgere da sensazioni che spesso ho provato, sentimenti che forse non dovrebbero sfiorare la mente di un credente, ma che pure ci sono e che quindi devono essere presi in mano e fatti oggetto di riflessione.
Quella che abbiamo letto è la terza Lamentazione, diversa dalle altre quattro che compongono con lei il breve libro dell’antico testamento. Già la denominazione “Lamentazioni” ci fa capire che potremmo trovare in questo libro parole di sconforto, espressioni di dolore, infatti possiamo leggere tutto lo strazio dei sopravvissuti alla distruzione del tempio e alla devastazione di Gerusalemme.
Potremmo dire che quelle sono lamentazioni “pubbliche”, di tutto un popolo che soffre per la distruzione della città simbolo di Israele, mentre quella che abbiamo letto per la meditazione di oggi è invece “privata”, o meglio individuale.
Perché “privata”? Abbiamo sentito che inizia con “Io sono l’uomo che ha visto l’afflizione…”; è il lamento di una singola persona che guarda essenzialmente al proprio dolore.
Il lamento di un singolo inserito nel cuore della disperazione collettiva, infatti delle cinque lamentazioni questa è la terza, la centrale. E questo probabilmente non è un caso, perché denota che, anche nel cordoglio collettivo, nella sofferenza contemporanea di migliaia di persone, ognuno porta il peso del proprio dolore individuale, un dolore unico e diverso.
Ancor oggi facciamo questa esperienza, quando nei disastri collettivi oppure negli sconvolgimenti di intere popolazioni per guerre e fame, sentiamo il dolore dei singoli individui che parlano della loro individuale disperazione perché hanno perso tutto oppure perché raccontano le loro sofferenti esperienze di vita.
E nello strazio individuale noi che ascoltiamo scorgiamo la sofferenza di interi gruppi o di intere popolazioni, ben sapendo che non vale comunque a nulla il vecchio adagio “mal comune mezzo gaudio”, perché nello sgomento di un singolo individuo, nella sua sofferenza, possiamo vedere troppo spesso il dolore di interi gruppi o addirittura di intere popolazioni.
Allora, vediamo cosa dice del suo strazio personale (che è l’eco dello strazio del suo popolo) quest’ebreo di ventisette secoli fa.
L’avvio del passo biblico è subito incisivo e toccante: “Io sono l’uomo che ha visto l’afflizione”. Un uomo, una persona che ha sofferto nel corpo e nello spirito, un uomo il cui dolore arriva alla disperazione, perché conosce anche troppo bene la causa della sua sofferenza, e il suo sgomento è grande perché l’afflizione è causata dalla “verga del suo furore”.
Il “suo” furore. Ma allora quest’uomo sa bene che c’è un responsabile per tanto dolore! E questo responsabile per l’uomo ha un nome ben preciso: è Dio!
Le immagini riportate nelle descrizioni di tanta sofferenza cercano di esprimere ciò che non è descrivibile perché il dolore è così immenso che qualsiasi parola non riesce a comunicarlo. Meglio quindi cercare di addossare la colpa dello strazio a questo Iddio che, nella visione del sofferente, è stato l’artefice di un simile disastro: “Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca; mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l’accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino, e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce. Mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra”.
A ben pensarci sono immagini cruente, che toccano il cuore, che danno l’idea che quest’uomo non sa più chi è e si sente come fosse strappato via da sé stesso, completamente smarrito, come fosse condannato a non vedere più alcuna luce e speranza nella propria vita, in un completo disfacimento spirituale e fisico.
Questa è la disperazione di un uomo che si sente preda di un nemico che lo assedia e lo insegue, proprio come coloro che in Gerusalemme si sentivano tutti preda dei Caldei, prigionieri in una città affamata e assediata dal nemico.
E tutto questo è opera di Dio! Di quel Dio che ha permesso che la sua città venga distrutta, che il suo tempio devastato, che il suo popolo affamato e ucciso.
Ed è un Dio che non puoi dimenticare, anche se lo vorresti, perché lui non ti lascia, non si dimentica di te, ma ti afferra, ti stringe, ti blocca rendendoti prigioniero addirittura costruendo un muro, lasciandoti solo nella tua disperazione, un Dio perfino sanguinario e feroce, come un “orso in agguato” e “un leone” che s’appiatta nei nascondigli, pronto a balzarti addosso per sbranarti.
E sei sempre più solo. Sei tu con la tua disperazione. Sei tu col tuo dolore. Sei tu con la tua incapacità di muoverti, perfino di scappare, di reagire.
Capiamo noi quest’uomo? Credo proprio di sì, perché sono convinta che ognuno di noi abbia provato nella vita dolori forti, sgomento totale, perdita di ogni speranza e incapacità di credere che qualcosa possa cambiare. Se non lo abbiamo provato, possiamo ritenerci soddisfatti oppure possiamo forse pensare di aver guardato ai nostri accadimenti di vita con una certa superficialità, forse.
Quando sei nell’assoluta disperazione, quando ti senti solo attanagliato dall’angoscia e dal dolore, ti coglie la solitudine esistenziale, credi che nessuno possa percepire ciò che provi e magari ti lasci andare, cadi nello sfinimento completo, in quella situazione dove perfino il lamento si fa sempre più fievole, dove il pianto prende il sopravvento, un pianto che diventa quasi un monologo triste appena sussurrato, rivolto solo a noi stessi.
Così accade anche al nostro protagonista che dice: “È sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore!”
Ed ecco che, proprio quando la fine è ormai solo ad un passo, d’improvviso tutto cambia. Quest’uomo per la prima volta pronuncia il nome di Dio, anche se lo pronuncia dicendo che non ha più fiducia in lui.
Ma così dicendo, gli capita come a chi ha deciso di lasciare una persona amata e che però poi guarda per caso una sua fotografia, e capisce che non la può lasciare, perché magari ne è ancora innamorato/a.
Non è un esempio banale, perché il nome, nella Bibbia, è veramente come la foto di chi lo porta: ci permette di coglierne i lineamenti, il sorriso, lo sguardo, la sua essenza. E questo vale anche per il nome di Dio; per questo devi stare molto attento a pronunciarlo, a non dirlo invano, come sta scritto nella legge.
E il nostro autore della Lamentazione dice quel nome fino ad allora taciuto e si scopre ancora “innamorato perso” di colui che lo porta, “innamorato perso del suo Dio… e non soltanto questo: lui, in quel suo nome ancora amato nonostante tutto, coglie chi davvero sia il Signore, per il suo popolo ma soprattutto per lui: è il Dio sempre fedele e che c’è sempre, come colui che – sono le parole del profeta Osea, che forse a questo punto son risalite nella mente e nel cuore di questo antico figlio di Israele – “se ferisce, risana; se colpisce, anche guarisce” … colui che “ti ridà quella vita” che tu già pensavi di aver perso proprio per causa sua (cfr Osea 6,1 s.).
E allora veramente tutto cambia: quel Dio che prima era come un “orso” e un “leone”, adesso è nuovamente il Dio dell’Alleanza, è il tuo Dio, il Signore del dono e della grazia, che ha scelto Israele come suo, e che dentro Israele ha scelto te, ed è con te e per te, in ogni istante della tua esistenza.
Ecco allora la nuova “ripartenza”, la speranza che torna ad illuminarsi, la voce che s’innalza limpida e gioiosa: ”Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti; le sue compassioni infatti non sono esaurite; si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà! «Il Signore è la mia parte», io dico, «per questo spero in lui». Il Signore è buono con quelli che sperano in lui, con chi lo cerca.”
E quando la voce torna a farsi limpida, anche la mente si fa di nuovo lucida ed ecco allora che l’uomo che ha scritto questo canto, va avanti ad indagare nel mistero della sofferenza, ne scopre tutti gli aspetti insospettati e, un poco, anche le cause. E sebbene abbia espresso, fino ad un momento prima, tutto il suo orrore per quello che soffriva e ancora soffre, ora non ha paura a penetrare più a fondo nell’abisso, perché sa che così – e soltanto così – potrà risentire in sé stesso la capacità di ritornare a Dio e riamarlo, nonostante le sue quotidiane percosse dolorose.
Guardiamo, sorelle e fratelli, con attenzione e disponibilità di comprensione alla vicenda personale dell’autore della terza Lamentazione, alla sua riscoperta di Dio nata dall’aver pronunciato il suo nome e notiamo come, nella seconda parte di questo canto, il nome del “Signore”, che nella prima parte non era mai stato nominato, torni continuamente, quasi che, riscoperto, l’autore s’incanti a pronunciarlo, per provare (ogni volta e ogni volta di nuovo) la gioia che ha sentito quella prima volta che se l’è trovato sulle labbra.
Per molti aspetti anche noi oggi siamo in crisi ed anche oggi abbiamo bisogno di riflettere su queste parole. Per rinnovare la nostra speranza, ma soprattutto, per riscoprire lui, per riscoprire chi davvero è il nostro Dio, nella sua grandezza e anche perfino nella sua fragilità, nella sua vulnerabilità.
Già, quella vulnerabilità di chi ama e per amore espone e mette in gioco tutto sé stesso. Quella vulnerabilità che abbiamo visto in Gesù, nella sua morte per la nostra salvezza, nella sua passione per il nostro riscatto, nella sua delusione per essere stato molte volte incompreso perfino dai suoi, nel suo sforzo di farsi sentire da noi, sordi e distratti, spesso chiusi nei nostri piccoli e grandi dolori che ci rendono sordi alla voce della speranza, ci fanno concentrare solo sui nostri problemi, dimenticando spesso che, se smettiamo di guardare al nostro ombelico, potremo forse vivere un po’ meglio anche nelle nostre sofferenze e potremo imparare a “com-patire” con il nostro prossimo. E potremo allora esclamare tutti insieme, con meraviglia e con riconoscenza: ”Il Signore è dalla mia parte, per questo spero in lui”.
AMEN
Liviana Maggiore