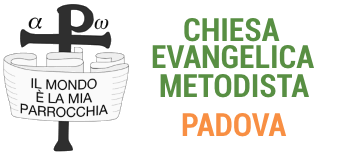IL SOLE, LA LUNA E LE STELLE
Vorrei raccontarvi una storia, la storia dell’umanità e del sole, della luna e delle stelle. Una storia che inizia nel principio, per usare le parole bibliche, perché gli astri, da sempre, prima di noi, hanno il loro posto sopra di noi.
Sono proprio sole, luna e stelle che permettono e regolano la vita umana: il sorgere e il tramontare del sole e della luna scandiscono il tempo, il passare dei giorni, dei mesi, delle stagioni; ma anche regolano l’alternarsi del buio e della luce, del caldo e del freddo, e quindi della semina e del raccolto; senza dimenticare la possibilità di orientarsi… gli astri, nel principio, non erano solo compagni di viaggio, ma strumenti essenziali del viaggio, erano ciò che faceva la differenza fra carestia e abbondanza, benessere e povertà, salute e malattia.
Ma ecco che un giorno Mosè dice al popolo di Israele:
badate bene a voi stessi, … affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l’esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro un culto, perché quelle sono le cose che il SIGNORE, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. (Deuteronomio 4,15.19)
Badate bene di non cedere alla tentazione di prostrarvi davanti a sole, luna, stelle, pianeti…
Ci fa quasi sorridere l’idea di pregare o offrire sacrifici a sole, luna e stelle per ricevere in cambio un buon raccolto, ricchezza, salute…
Eppure, se ci pensate, noi non siamo molto diversi dal popolo di Israele. Certo, non preghiamo e non ci prostriamo davanti a pianeti e stelle, e non ci lasciamo spaventare dai segni nel cielo, ma non lo facciamo solo perché non ne abbiamo bisogno: infatti noi sappiamo.
Noi possediamo le conoscenze e le tecniche necessarie per spiegare, ma anche sfruttare e costringere alla nostra volontà il tempo, la luce, il calore. Possiamo alzare e abbassare la temperatura a nostro piacimento; possiamo coltivare qualsiasi prodotto in qualsiasi posto e in qualsiasi stagione; possiamo rallentare o accelerare i processi di crescita. Non temiamo più gli astri e non cerchiamo di compiacerli, perché non sono più indispensabili: adesso possiamo appropriarci delle loro funzioni.
Anche per noi, come per il popolo di Israele, la creazione non è solo dono da accogliere con gratitudine e da condividere; la creazione è qualcosa di cui impadronirsi, da sottomettere e controllare; è una ricchezza da sfruttare.
Quasi senza accorgercene anche noi ci siamo costruiti delle divinità che richiedono attenzione, sacrifici, compromessi. Chi possiede acqua, aria, sole, terra, vento ha potere, ricchezza, energia, vita. Non c’è più gioia, né canto, né lode nelle parole della creazione: non siamo più compagni, non viviamo più gli uni per l’altra. Il nostro è diventato sempre più il tempo dello sfruttamento e della violenza.
Ma questo è solo l’inizio della storia, che continua con le parole di un narratore d’eccezione, il profeta Isaia:
Ecco il giorno del Signore giunge: giorno crudele, di indignazione e di ira furente,
che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori.
Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce;
il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore.
Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità;
farò cessare l’alterigia dei superbi e abbatterò l’arroganza dei tiranni. (Isaia 13,9-11)
Sorelle e fratelli, gli astri, le stelle, le costellazioni, il sole, la luna, sono creati per testimoniare il Creatore perché il progetto di Dio per noi comprende e coinvolge ogni elemento del creato. E quando noi ci allontaniamo da questo progetto, un progetto di amore, giustizia, salvezza, benessere, gli astri stessi ci avvertono.
Il giorno del Signore è il giorno in cui ci confrontiamo con la volontà di Dio per noi. E in quel giorno la terra diventa deserto, le stelle e le costellazioni non brillano, il sole che sorge si oscura e la luna non splende più.
Gli effetti della nostra gestione della creazione, li stiamo vedendo già da qualche anno: cambiamenti climatici, ghiacciai che si sciolgono, innalzamento del livello del mare, scomparsa di interi piccoli arcipelaghi, migrazioni di persone ma anche di animali, deforestazione e incendi, coltivazioni intensive che impoveriscono la terra e le popolazioni… e spesso per contrastare gli effetti delle nostre scelte sbagliate, non facciamo che aggravare la situazione. In nome di uno sviluppo al quale non possiamo assolutamente rinunciare, cerchiamo sempre più di controllare lo scorrere del tempo, l’intensità della luce, le fonti di energia piegando la creazione alle nostre esigenze.
Continua Isaia:
In quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l’esercito di lassù,
e giù sulla terra i re della terra;
La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna (Isaia 24,21.23)
Così aveva detto il Signore:
«Nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza;
nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza».
Ma voi non avete voluto!
Avete detto: «No, noi galopperemo sui nostri cavalli!»
E per questo galopperete!
Tuttavia il SIGNORE desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia;
Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra,
le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: «Questa è la via; camminate per essa!»
Egli ti darà la pioggia per la semenza con cui avrai seminato il suolo,
e il pane, che il suolo produrrà saporito e abbondante.
Sopra ogni alto monte e sopra ogni elevato colle ci saranno ruscelli, acque correnti
La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte più viva,
come la luce di sette giorni assieme (Isaia 30,15-16.18.21.23-26)
Fino a quando? È questa la domanda che con sempre più insistenza ci viene rivolta dai nostri fratelli e sorelle dei Paesi che più subiscono la nostra violenza, o la nostra indifferenza.
Fino a quando ci ostineremo a credere di essere noi a controllare il mondo e le sue risorse?
Fino a quando continueremo ad imporre a tutti e a tutto le nostre priorità, i nostri progetti, il nostro stile di vita?
Fino a quando continueremo ad illuderci di essere i sovrani del creato, invece che gli amministratori della creazione e i servitori delle creature di Dio?
Quel giorno, il giorno in cui il Signore ci ricorda che è lui la fonte della nostra vita, la sorgente della nostra energia, il senso della nostra storia, perfino la luna e il sole arrossiscono per la vergogna e ci sembra che non ci sia più nulla da fare, nessuna speranza.
Eppure le parole di Isaia non sono prive di speranza, perché Dio non smette di suggerirci la strada da percorrere, nonostante le nostre reticenze. Dio conosce la nostra umanità, la nostra fragilità, le nostre paure e ci assicura che, quando torneremo e ci affideremo a lui, collaborando al suo progetto di salvezza, allora l’ordine della creazione sarà ristabilito e il sole e la luna brilleranno di una luce mai vista perché lui stesso sorgerà e donerà la sua luce e il suo calore.
Non più il sole sarà la tua luce, nel giorno;
e non più la luna t’illuminerà con il suo chiarore;
ma il SIGNORE sarà la tua luce perenne.
Il tuo sole non tramonterà più,
la tua luna non si oscurerà più;
poiché il SIGNORE sarà la tua luce perenne,
i giorni del tuo lutto saranno finiti. (Isaia 60,19-20)
Il sole, la luna, le stelle e noi… e ancora Dio.
È una storia che viene scritta giorno dopo giorno, e ognuno di noi ne scrive una pagina: le nostre scelte, le nostre azioni, la nostra testimonianza non sono indifferenti.
Quale sarà il finale? Nonostante tutto, Isaia è certo che il lieto fine non mancherà. Forse cambieremo mentalità, forse riconosceremo finalmente tra le tante voci che tentano di convincerci, la voce di Dio che ci indica la strada giusta da percorrere, forse riusciremo alla fine a sentirci compagni e compagne del mondo in cui viviamo… quello che è certo è che Dio non ritirerà la sua promessa: la sua luce continuerà ad illuminare il nostro buio, il suo calore continuerà a infondere coraggio, il suo amore accompagnerà sempre il nostro cammino.
Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più;
poiché il SIGNORE sarà la tua luce perenne,
Amen.
Pastora Daniela Santoro