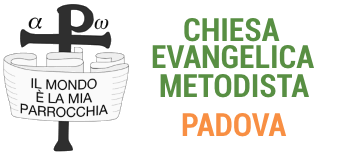Sermone: LA VITE E I TRALCI
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo recide; ma ogni tralcio che porta frutto, lo purifica affinché ne porti di più. Voi siete già puri per mezzo della parola che vi ho annunciata. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutti da sé stesso se non rimane nella vite, così nemmeno voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me e io in lui, porta un frutto abbondante; perché senza di me non potete far nulla. Se uno non rimane in me, viene gettato via come il tralcio e si secca; poi li raccolgono, li gettano nel fuoco e bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così io ho amato voi; rimanete nel mio amore». (Giovanni 15,1-9)
Bellissimo questo passo dell’evangelo di Giovanni! Personalmente è uno dei passi della scrittura che più ho amato fin da giovane e sul quale spesso mi sono trovata a riflettere da sola o in compagnia.
Oggi con voi vorrei fare alcune considerazioni in merito alla narrazione sulla vigna ed ancora sul fatto che in questi 9 versetti compare ben 7 volte il verbo “rimanere” che, nella traduzione della BIR ha sostituito il verbo “dimorare” della Riveduta, però con il medesimo significato.
LA VIGNA – Nella Bibbia si parla spesso di questa pianta, tanto che, come abbiamo sentito nelle letture precedenti, Israele viene paragonata alla vigna del Signore. Credo che l’importanza data a questa pianta derivi dal fatto che il frutto della vigna, di una buona vigna, è l’uva e dall’uva si ricava il vino, una bevanda che era ed è utilizzata per festeggiare, per gioire, per condividere il piacere con gli altri, quindi una bevanda importante nel costume sociale di tutti i tempi. Ma non sempre il vino nella scrittura è simbolo di gioia, infatti viene anche presentato come una “bevanda traditrice” perché inebria e per questo da bere senza eccesso, oppure come simbolo del sangue di Cristo. Tuttavia sono molti i passi della Bibbia dove il vino è visto con approccio positivo, così come sono moltissimi i passi in cui si parla della pianta che dà l’uva.
Anche se non sono un’esperta di coltivazioni viti-vinicole, so bene, come lo saprete anche voi, che la vite ha un fusto robusto, dai cui rami scendono i tralci che porteranno l’uva.
Ebbene, in questo passo di Giovanni, Gesù dice che noi siamo i tralci, cioè siamo quella parte della pianta che sta fra il fusto e il frutto. Ma per dare buoni frutti i tralci devono essere ben saldi sulla pianta dalla quale devono trarre la linfa, la forza, per dare e sostenere buoni grappoli.
Nel racconto che abbiamo letto Gesù si paragona alla pianta ed afferma che il Padre è il vignaiolo. Noi quindi, coloro che credono in Cristo, dovremmo essere consapevoli che non siamo tutta la pianta e che, se non diamo il frutto sperato, se ci secchiamo, il vignaiolo provvede a recidere.
RIMANERE – “Rimanete in me”. È questa l’esortazione principale di Gesù in questo passo. Già, rimanere in lui, così che Egli rimanga in noi. È così importante questo concetto di rimanere, di dimorare, in Cristo da essere continuamente ripetuto. Rimanere saldamente in lui così come i tralci devono essere saldamente attaccati alla vigna. Rimanere in lui per non seccarci, per godere della linfa vitale che non si ferma al tralcio, ma nutre anche il frutto.
Mi viene una considerazione in proposito: se rimaniamo saldamente ancorati agli insegnamenti di Gesù siamo tralci produttivi, però dobbiamo avere la consapevolezza che siamo sempre e solo tralci, non siamo la pianta che affonda le radici nel terreno e non certo il frutto dal quale poi si trarrà il vino. Il tralcio sta nel mezzo, non è l’inizio e non è la fine del fluire della linfa. Il tralcio succhia la linfa dalla pianta, come noi possiamo trarre insegnamento e forza dalla parola del Signore, però cede parte della sua forza al frutto, affinché cresca buono e succulento. E una pianta può avere moltissimi tralci, alcuni dei quali verranno recisi perché non porterebbero frutto.
Ecco, così è la nostra missione: nella consapevolezza di essere solo dei mezzi per passare la linfa vitale, degli annunciatori della Parola, dei discepoli del maestro, noi dobbiamo condurci nei rapporti con gli altri sapendo che abbiamo l’incarico di produrre frutto, ma dobbiamo anche sapere che il frutto non resterà attaccato a noi, il frutto non apparterrà mai al tralcio. Io credo che, se noi riflettessimo su questo nostro ruolo di discepoli, consapevoli di essere solo dei mezzi, molti dei nostri sensi di onnipotenza verrebbero ridimensionati, perché spesso, nella nostra vita, non riusciamo ad accettare che il frutto, cioè coloro che ricevono da noi l’annuncio della parola (e lo ricevono con il nostro dire, ma soprattutto con il nostro agire), è completamente indipendente e libero da noi.
Ma che cos’è la linfa che passa dal tralcio, qual è la forza vitale che Gesù dice di darci quando afferma sia così potente da concederci di avere dal Padre tutto ciò che chiederemo?
Qual è il grande alimento che riceviamo dagli insegnamenti di Gesù, tanto grande da fargli dire che Egli resterà sempre in noi, mettendoci quindi in una relazione indissolubile col Padre?
L’ultimo versetto che abbiamo letto recita: “Come il Padre mi ha amato, così io ho amato voi; rimanete nel mio amore”. Eccolo l’alimento! Ecco ciò che abbiamo gratuitamente ricevuto e gratuitamente dobbiamo porgere agli altri come discepoli di Gesù: l’amore, linfa vitale per ciascun essere umano e per l’umanità tutta.
Ma cosa intendiamo per “amore”? Certo è facile parlare d’amore con le persone a cui vogliamo bene, con coloro che sono cari al nostro cuore, ma, volando un po’ più in alto delle nostre ridotte vite di relazione, diventa più difficile definire l’amore e magari rischiamo di interpretarlo come un vago sentimento buonista che ci consente di metterci in contatto con gli altri solo per lusingare il nostro ego.
Per sapere invece cos’è l’amore nella dimensione di credenti dobbiamo rifarci ancora una volta al nostro maestro, a colui che ha condiviso con noi tutto ciò che sapeva, tutto ciò che aveva, compresa la sua stessa esistenza terrena, morendo in croce per noi, perché, come abbiamo letto nel passo di Giovanni per l’annunzio del perdono, “nessuno ha amore più grande di questo: donare la sua vita per i suoi amici”.
Ora, comprendo bene che la maggioranza di noi non è votata al martirio e comprendo bene che, nella nostra situazione sociale, non ci viene fortunatamente richiesto di dare la nostra vita, di immolarci fino alla morte per gli altri (tanti credenti però l’hanno fatto e continuano a farlo), però è altrettanto vero che, come discepoli del Signore, ci viene chiesto di spargere amore, cioè di condividere con il nostro prossimo ciò che abbiamo e ciò che siamo. Condividere non solo il surplus che ci avanza, ma condividere l’unico mantello che abbiamo con chi è ignudo. Mettere a disposizione il nostro tempo, i nostri averi, le nostre conoscenze, il nostro essere non solo quando ne abbiamo voglia, ma soprattutto quando alla nostra porta bussa qualcuno che non conosciamo, che non aspettavamo e che magari non vedremo più.
Il tralcio non giudica quanta linfa debba passare al frutto. Ne tiene una parte come proprio alimento e poi la cede tutta. Così dovremmo fare anche noi, per amore, con tutti i doni che abbiamo ricevuto, materiali e immateriali.
AMEN
Liviana Maggiore